La
strana intimità di quelle due rotaie. La certezza di non incontrarsi mai. L’ostinazione
con cui continuano a corrersi di fianco. Gli ricorda qualcosa, tutto questo.
Quando
un giorno qualcuno scriverà una storia della letteratura italiana di fine
secolo, e come sempre accade con il passare del tempo saranno sopite le
polemiche, estinte le piccinerie e le acrimonie, perdonate le immodestie,
svaporate le invidie che si agitano nel mondo delle lettere, quel qualcuno
dovrebbe accorgersi che il torinese Alessandro Baricco ha squarciato come un
fulmine il cielo stantio della cultura italiana dell’ultimo decennio del ’900,
e tributargli il dovuto riconoscimento, fosse solo per aver scritto un libro
come Castelli di rabbia, indipendentemente dalla sua produzione successiva.
Di
solito Baricco lo si ama o lo si odia, non ci sono vie di mezzo: c’è chi
stravede per la sua letteratura e chi la disprezza, chi lo ritiene un divo
delle lettere e chi lo relega nella paccottiglia della pseudoletteratura
postmoderna fatta di niente. Qui giocano molto i sentimenti, le visioni del
mondo, i paesaggi delle proprie emozioni, e anche parecchia supponenza: ho
sentito affermare che la scrittura di Baricco è insulsa, ma chi lo diceva come
metro di paragone letterario poteva vantare, sì e no, appena le antologie
scolastiche; altri dotti sedotti dallo stile accattivante si sgolano in peana
celebrativi del più originale scrittore italiano, senza aver mai letto, per
esempio, Marinetti o Gadda. È qualcosa che si agita in pancia, insomma, a dire
l’ultima parola, a decretare il podio nell’Olimpo degli Scrittori. Per la gente
di mestiere ci sono altre implicazioni, non sempre limpide…
[...]Durante
un’intervista, il vanitoso (a ragion veduta) e peraltro ancora ingenuo
Alessandro Baricco, alla domanda (poco originale): perché hai scritto questo
libro, se ne esce candidamente con questa risposta (molto originale): perché
era il libro che volevo leggere e non trovavo da nessuna parte. Complimenti.
Eppure,
immediata antipatia a parte, questa risposta contiene già tutta la cifra
dell’autore: Baricco viaggia a frequenze letterarie piuttosto alte per la media
italiana, comunica l’idea che la letteratura dovrebbe essere qualcosa di
travolgente e appassionante, un incanto, una materia da sogno come sapevano
lavorarla Flaubert, Salinger, Gadda, Dickens, Conrad, Céline, tanto per citare
alcuni dei suoi autori preferiti, e tuttavia nuova, mai fatta prima, svelando
anche il dato, indiscutibile, che una simile letteratura nell’Italia di allora
non c’è (e forse non c’è nemmeno oggi). All’epoca ciò che causò un certo
fastidio non fu tanto la superbia di tale atteggiamento (peraltro piuttosto
diffusa nel mondo delle lettere) quanto il fatto che un intero modo di scrivere
e di interpretare la letteratura venisse colato a picco da un esordiente di
trentatre anni, un signor nessuno a quei tempi, con un romanzo inimitabile che
raggiunse subito la cinquina finalista del Premio Campiello 1991.
Tante
cose che si dicono sul conto di Baricco, alcune vere e altre pure malignità,
sul fatto che lui sia un animale da palcoscenico, che sia diventato qualcuno
solo grazie alla televisione, che sia un abile affabulatore, più un
comunicatore che uno scrittore, e così via, rapportate all’epoca non reggono:
niente tv, qualcosa alla radio, qualche articolo di critica musicale, uno
studio difficilissimo (per chi non ha dimestichezza con il linguaggio
filosofico e con le architetture musicali) su Rossini, e perciò passato
inosservato. Tutto qui.
Castelli
di rabbia, scritto presumibilmente tra il 1988 e il 1990 (calcolo mio e del
tutto opinabile), è talmente innovativo che l’editore inizialmente ha qualche
dubbio sull’opportunità commerciale del testo: il libro è bello, gli dice, ma
lo leggeranno pochi. Se Baricco fosse stato un giovane di belle speranze, che
senza nessun aggancio spedisce per posta il suo manoscritto all’editore
aspettando fiducioso una risposta, avremmo corso il rischio di non conoscere
mai la sua opera. Ma Baricco l’aggancio ce l’ha. Cito da un’intervista
rilasciata al Corriere della Sera nel 2003: “A decidere di pubblicare Castelli
di rabbia fu Gianandrea Piccioli, ma il mio capo in Rizzoli era Giovanni
Ungarelli (…)”. Può avere sbagliato termine (difficile però, conoscendolo), ma
uno che parla di un “suo capo”, mi vien da pensare, con quella persona ha già
un rapporto di lavoro (editor? correttore di bozze?). Comunque sia, Baricco
conosce Ungarelli e Ungarelli conosce Baricco, e in Rizzoli lo stimano al punto
di decidere la pubblicazione del romanzo nonostante tutto: improvviso e
inaspettato successo, di critica e di pubblico.
Eppure
Castelli di rabbia non è il libro di maggior successo di Alessandro Baricco. Da
una statistica, per quanto datata ma che racchiude i risultati raggiunti in un
decennio, leggo che mentre Oceano mare è arrivato a 650.000 copie vendute, Seta
a 730.000, Castelli di rabbia si attesta solo (solo…) su 465.000 copie (dati
del 2002). Fatte salve nuove e più aggiornate statistiche commerciali, le cifre
possono suggerire qualche indizio sulla successiva dinamica delle opere di
Baricco, sempre di valore ma in qualche modo addolcite, rettificate, smussate
di quelle asperità stilistiche e strutturali, ma anche di quelle esagerazioni
dovute allo sperimentalismo entusiasta di un giovane scrittore, che possono
intimorire o irritare i lettori. Che Alessandro Baricco sia particolarmente
attento ai gusti e alle aspettative del pubblico, lo si può ricavare anche da
un suo Barnum, dove a proposito di “cannibali” e affini, dice più o meno: se il
mondo delle lettere diventerà questo, ci adatteremo, però di notte giù in
cantina a leggere Melville (sarebbe interessante approfondire il rapporto
nostalgia del passato-curiosità del nuovo nella poetica di Baricco).
E
dunque, Castelli di rabbia. Leggere questo romanzo è una vera soddisfazione
intellettuale difficilmente comparabile. La preziosità e la freschezza della
scrittura ti prende e non ti porta propriamente da nessuna parte, nel senso che
ti fa viaggiare in un paesaggio multiforme dove vedi tutto senza mai chiederti
dove tu stia andando. In altre parole il romanzo, è questa una delle sue
caratteristiche innovative, non ha un fine e nemmeno una fine propriamente
detta (c’è chi sostiene che Baricco sbaglia tutti i finali dei suoi romanzi: in
realtà credo che quel tipo di finale/non finale sia voluto, come le frasi senza
punto e incompiute che si trovano nelle sue pagine), non è teleologico, non ci
vuole dire niente di definitivo. Immaginate che anziché narrare una storia
secondo la sua linearità naturale, si trascuri la sequenza logica, cronologica
e teleologica dei fatti e si racconti del tizio che fabbricò un oggetto, delle
implicazioni esistenziali e filosofiche relative al fatto che siano state inventate
certe macchine, con qualche digressione storica stile monografia, si lascino
irrompere sconosciuti (non-personaggi) che raccontano qualcos’altro, si
inseriscano battute spiritose, pezzi di comicità, dialoghi spezzati, dialoghi
spiazzanti, monologhi non interpellati, ripetizioni di ritmo, il silenzio
abbagliante di spazi e pagine bianche, aforismi incongrui, voci imperfette,
materiali eterogenei, anche grafici, che si inseguono fino a cadere là dove
devono cadere, svelando una traccia, un indizio, un’ipotesi, o forse soltanto
l’illusione di aver compreso una direzione, per poi virare e spingersi altrove,
mantenendo tuttavia una rotta invisibile, tale per cui la trama della fatalità
letteraria c’è ma non si vede, e tutto è soltanto paesaggio. Ecco, Castelli di
rabbia è più o meno così.
Il
collante di questa polifonia o polilogia è il linguaggio, la voce narrante
dell’autore che uniforma nell’espressione il tutto, però attraverso una
pluralità di registri formali non caratterizzanti i personaggi, peraltro
allegorici (cfr. Alessandro Scarsella, Alessandro Baricco): l’analfabeta si
esprime come l’istruito, lo straniero come il nativo, ma lo fa ora con il
registro lirico, ora con quello aulico, ora con quello volgare, ora con quello
teatrale, senza preavviso, senza cioè introdurre il contesto del dialogo e
senza finalità descrittiva o esplicativa della narrazione.
Baricco
non ha inventato i singoli componenti formali dell’opera (rinvenibili
separatamente in una vasta gamma di autori, soprattutto stranieri, dalla pagina
bianca di Sterne all’onomastica astrusa alla Dickens, fino a certe
asintatticità di Céline e alla famosa barra / che ricorda Derrida, benché
Baricco la usi come ulteriore e nuovo segno di punteggiatura – di partitura
musicale quasi – e non come distinzione-rivelazione di disseminazione
semantica), ha inventato un nuovo modo di assemblarli, e qui sta la sua
genialità creativa, la capacità di rievocare atmosfere ottocentesche
ricostruite con il montaggio di un film americano (cfr. Fernanda Pivano,
L’ultima parola: America, prefazione a Castelli di rabbia) e di emozionare il
lettore come nessun revival ottocentesco e nessuna americanata potrebbero mai
fare.
Qui
c’è tanto talento, passione e sapienza: non so quantificare il volume di libri
letti da Baricco prima di mettersi a scrivere, certo che la sua laurea in
Filosofia Estetica con tesi su Adorno deve avergli fornito parecchio materiale
di indagine, vale a dire tecniche e trucchi del mestiere.
Eppure
le caratteristiche che fanno di Castelli di rabbia una novità preziosa, una
vetta di abilità e di sofisticata talentuosità nella palude degli anni Ottanta,
sono le stesse che leggono e interpretano il cambiamento della cultura,
determinando la morte del letterario consolidato nella tradizione italiana e
spalancando le porte ad una nuova narrativa (postmoderna?)[...]
Dopo
un romanzo come questo, nulla, in letteratura, potrà più essere come prima.
Mauro
Del Bianco
E’ strano come alle volte non ci sia proprio nulla da dire...
Di
Baricco ho conosciuto prima di tutto le frasi di Castelli di rabbia,
quelle che ti arrivano come un pugno in faccia, ti sconquassano lo stomaco e
senti dentro di te, tue parole per le tue emozioni.
Ammetto di avere comprato
questo libro essenzialmente per questo motivo e le ho ritrovate tutte e qualcuna in più.
Ma il contesto di quelle frasi era tutt’altro rispetto a quello che avevo immaginato: la storia quasi buffa
di un uomo che insegue il sogno di far viaggiare una locomotiva per duecento
chilometri...
Eppure queste pagine mi hanno lasciato qualcosa di indefinibile dentro, una strana
dolcezza, una strana disillusione, l’idea di un amore diverso e la certezza che
l’essere normali, in fondo, non è sinonimo di infelicità.
Lo stile è
altrettanto eccezionale in alcuni punti, sorprende e ti schiaffeggia anch’esso,
forse più dei contenuti.
“Di
solito Baricco lo si ama o lo si odia, non ci sono vie di mezzo”? A me Baricco è piaciuto.
Castelli di rabbia...
“Un
giorno Dio disegnò la bocca di Jun Rail. E’ lì che gli venne quell’idea stramba
del peccato.”
Così
fa il destino: potrebbe filar via invisibile e invece brucia dietro di sé, qua
e là, alcuni istanti, fra i mille di una vita. Nella notte del ricordo, ardono
quelli, disegnando la via di fuga della sorte. Fuochi solitari, buoni per darsi
una ragione, una qualsiasi.
Perchè
è così che ti frega la vita. Ti piglia quando hai ancora l’anima addormentata e
ti semina dentro un’immagine, o un odore, o un suono che poi non te lo togli
più. E quella lì era la felicità. Lo scopri dopo, quand’è troppo tardi. E già
sei, per sempre, un esule: a migliaia di chilometri da quella immagine, da quel
suono, da quell’odore. Alla deriva.
Semplicemente,
senza che un solo angolo del suo volto si muovesse, e assolutamente in
silenzio, iniziò a piangere, in quel modo che è un modo bellissimo, un segreto
di pochi, piangono solo con gli occhi, come bicchieri pieni fino all’orlo di
tristezza, e impassibili mentre quella goccia di troppo alla fine li vince e
scivola giù dai bordi, seguita poi da mille altre, e immobili se ne stanno lì
mentre gli cola addosso la loro minuta disfatta. Così piangeva Jun.
C’è
la luce, tutt’intorno, della sera. Il sole ti piglia di fianco, quand’è così,
un modo più gentile, si coricano le ombre a dismisura, è un modo che ha dentro
qualcosa di affettuoso – ciò forse spiega com’è che, in generale, sia più
facile pensarsi buoni, la sera – quand’invece a mezzogiorno si potrebbe anche
ammazzare o peggio: pensare di ammazzare, o peggio: accorgersi che si potrebbe
anche essere capaci di pensare di ammazzare. O peggio: farsi ammazzare.
I
desideri sono la cosa più importante che abbiamo e non si può prenderli in giro
più di tanto. Così, alle volte, vale la pena di non dormire pur di stare dietro
a un proprio desiderio. Si fa la schifezza e poi la si paga. E solo questo è
davvero importante: che quando arriva il momento di pagare uno non pensi di
scappare e stia lì, dignitosamente, a pagare. Questo è l’importante.
Scrivere
una cosa significa possederla – illusione verso cui inclina una non
significante parte di umanità. Pensò a centinaia di pagine zeppe di parole e
sentì che il mondo gli faceva molto meno paura.
Il
sesso cancella fette di vita che uno nemmeno si immagina. Sarà anche stupido,
ma la gente si stringe con quello strano furore un po’ panico e la vita ne esce
stropicciata come un bigliettino stretto in un pugno, nascosto con una mossa
nervosa di paura. Un po’ per caso, un po’ per fortuna, spariscono nelle pieghe
di quella vita appallottolata mozziconi di tempo dolorosi, o vigliacchi, o mai
capiti.
Così
mi gira l’anima dentro, triturandosi gli attimi e gli anni – perversa rotazione
onnipotente – chissà se c’è un modo per fermarla, chissà se è fermarla che si
deve – chissà se è proprio scritto che debba fare male così. [...] Venga
qualcuno e silenziosamente la fermi, l’ammutolisca in un angolo di vittoriosa
quiete, la sciolga per sempre nel fango di una vita qualunque da scontare in un
tempo senza ormai più ore – o la faccia finita in un attimo senza memoria – in un
attimo – la faccia finita.
Un
libro aperto è sempre la certificazione della presenza di un vile – gli occhi
inchiodati su quelle righe per non farsi rubare lo sguardo dal bruciore del
mondo. [...] La più raffinata delle ritirate, questa è la verità. Una
sporcheria. Però: dolcissima. [...] Chi può capire qualcosa della dolcezza se
non ha mai chinato la propria vita, tutta quanta, sulla prima riga della prima
pagina di un libro? No, quella è la sola e più dolce custodia di ogni paura –
un libro che inizia.
Gli
saliva dentro una tristezza antica e sapeva che non doveva lasciarla arrivare
dove avrebbe cominciato a far male davvero.
E’
strano come alle volte non ci sia proprio nulla da dire...
Il
fatto è che certe volte si ha dentro quella stanchezza brutta, così, passa la
voglia di continuare, di resistere... viene quella confusione in testa, e
quella stanchezza... così non è bello, poi, quando arriva la notte, non è
proprio il momento per starsene lì nel buio, da soli... proprio non ci vorrebbe
quella storia della notte...
Quel
che di bello c’è nella vita è sempre un segreto... per me è stato così... le
cose che si sanno sono le cose normali, o le cose brutte, ma poi ci sono dei
segreti, ed è lì che si va a nascondere la felicità.
La sera,
come tutte le sere, venne la sera. Non c’è niente da fare: quella è una cosa
che non guarda in faccia nessuno. Succede e basta. Non importa che razza di
giorno arriva a spegnere. Magari era stato un giorno eccezionale, ma non cambia
nulla. Arriva e lo spegne. Amen. Così anche quella sera, come tutte le sere,
venne la sera.
Crepita,
la vita, brucia istanti feroci e negli occhi passa anche solo a venti metri da
lì, non è che un’immagine come un’altra, senza suono e senza storia.
Comunque non sarebbe successo se uscendo
non fosse passato proprio davanti a quello specchio, così che dovette fermarsi
e tornare indietro, per mettersi davanti allo specchio, immobile. E guardarsi.
Lascia che bruci, quella candela, non
spegnerla, per favore. Se mi vuoi bene non spegnerla.
Però...
Però quando la gente ti dirà che hai sbagliato... e avrai errori dappertutto
dietro la schiena, fottitene. Ricordatene. Devi fottertene. Tutte le bocce di
cristallo che avrai rotto erano solo vita....non sono quelli gli errori.....
quella è vita... e la vita vera magari è proprio quella che si spacca, quella
vita su cento che alla fine si spacca..... io questo l'ho capito, che il mondo
è pieno di gente che gira con in tasca le sue piccole biglie di vetro....le sue
piccole tristi biglie infrangibili..... e allora tu non smetterla mai di
soffiare nelle tue sfere di cristallo..... sono belle, a me è piaciuto
guardarle, per tutto il tempo che ti sono stato vicino... ci si vede dentro
tanta di quella roba..... è una cosa che ti mette l'allegria addosso... non
smetterla mai..... e se un giorno scoppieranno anche quella sarà vita, a modo
suo..... meravigliosa vita.
Ci
sono navi che si sono incagliate nei posti più assurdi. Una vita si può ben incagliare
in una faccia qualunque.
Dev’essere
così, questa cosa dei figli, pensò Horeau: nascono con dentro quello che, nei
padri, la vita ha lasciato a metà.
La
strana intimità di quelle due rotaie. La certezza di non incontrarsi mai. L’ostinazione
con cui continuano a corrersi di fianco. Gli ricorda qualcosa, tutto questo.
E’
sempre qualche meraviglioso silenzio che porge alla vita il minuscolo o enorme
boato di ciò che poi diventerà inamovibile ricordo. Così.
Alla
fine c’è sempre un mare dove sfociare, per qualsiasi fiume.
Dove
la vita brucia davvero la morte è niente – non c’è null’altro contro la morte –
solo quello – far bruciare la vita davvero.
Ognuno
ha il mondo che si merita. Io forse ho capito che il mio è questo qua. Ha di
strano che è normale. Mai visto niente del genere, a Quinnipak. Ma forse
proprio per questo, io ci sto bene. A Quinnipak si ha negli occhi l’infinito.
Qui, quando proprio guardi lontano, guardi negli occhi di tuo figlio. Ed è
diverso. Non so come fartelo capire, ma qui si vive al riparo. E non è una cosa
spregevole. E’ bello. E poi chi l’ha detto che si deve proprio vivere allo
scoperto, sempre sporti sul cornicione delle cose, a cercare l’impossibile, a
spiare tutte le scappatoie per sgusciare via dalla realtà? E’ proprio
obbligatorio essere eccezionali? Io non lo so. Ma mi tengo stretta questa vita
mia e non mi vergogno di niente: nemmeno delle mie sovrascarpe. C’è una dignità
immensa, nella gente, quando si porta addosso le proprie paure, senza barare,
come medaglie della propria mediocrità. E io sono uno di quelli. Si guardava
sempre l’infinito, a Quinnipak, insieme a te. Ma qui non c’è l’infinito. E così
guardiamo le cose, e questo ci basta. Ogni tanto, nei momenti più impensati,
siamo felici.
Accadono
cose che sono domande. Passa un minuto, oppure anni, e poi la vita risponde.
Addio
Dann. Addio, piccolo signor Rail, che mi hai insegnato la vita. Avevi ragione
tu: non siamo morti. Non è possibile morire vicino a te. [...] Adesso sono io
che vado lontano. E non sarà vicino a te che morirò. Addio mio piccolo signore
che sognavi i treni e sapevi dov’era l’infinito. Tutto quel che c’era io l’ho
visto, guardando te. E sono stata ovunque, stando con te. E’ una cosa che non
riuscirò a spiegare mai a nessuno. Ma è così. Me la porterò dietro, e sarà il
mio segreto più bello. Addio, Dann. Non pensarmi se non ridendo. Addio.
Ma
quando ti viene quella voglia pazzesca di piangere, che proprio ti strizza
tutto, che non la riesci a fermare, allora non c'è verso di spiccicare una sola
parola, non esce più niente, ti torna tutto indietro, tutto dentro, ingoiato da
quei dannati singhiozzi, naufragato nel silenzio di quelle stupide lacrime.
Maledizione. Con tutto quello che uno vorrebbe dire... e invece niente, non
esce fuori niente. Si può essere fatti peggio di così?
Per
uno che sta andando in galera, vedere una freccia che porta altrove dev’essere
come guardare in faccia l’infinito.
Lo stile
DUE - Cap.4
Un uomo, come un pendolo, che
corre instancabile avanti e indietro dalla casa alla strada.
Sotto il diluvio, un uomo,
come un pendolo impazzito, corre avanti e indietro dalla casa alla strada.
Nella notte, sotto il diluvio,
un uomo, come un pendolo impazzito, esce di corsa dalla sua casa, si ferma in
mezzo alla strada, poi torna precipitosamente dentro casa, e di nuovo corre
fuori, e di nuovo si scaracolla in casa, e sembra che non la smetterà mai.
Nella notte, sotto il diluvio,
un uomo, come un pendolo impazzito e fradicio, esce di corsa dalla sua casa, si
ferma in mezzo alla strada, insegue qualcosa nell'aria e nell'acqua
tutt'intorno, poi torna precipitosamente dentro casa, e di nuovo corre fuori, e
di nuovo si scaracolla in casa, e sembra che non la smetterà mai, come se fosse
stregato dai rintocchi della campana che in quel momento violano il buio e si
sciolgono nell'aria liquida dell'infinito acquazzone.
Undici rintocchi.
Uno sull'altro.
Lo stesso suono, per undici volte.
Ogni rintocco come se fosse l'unico.
Undici onde di suono.
E in mezzo un tempo innumerabile.
Undici.
Uno dopo l'altro.
Sassi di bronzo nell'acqua della notte.
Undici suoni impermeabili gettati nel marcio
dellanotte.
Erano undici rintocchi, schioccati nel diluvio
dallacampana che vigilava la notte.
Fu il primo - già il primo - a prendere a tradimento
l'anima di Pekish, e a bruciarla.
TRE – Cap.2
(gli spazi sono voluti e sono molto più ampi nel
libro. Questo brano occupa 6 pagine)
Adagio. Adagio come se stessi camminando su una
ragnatela.
Adagio.
Come un tarlo.
Si continuava a chiedere se mai lo avrebbe perdonato.
621. Demoni. Angeli andati a male. Però bellissimi.
Il muschio. Ecco: il muschio.
Comunque non sarebbe successo se uscendo
non fosse passato proprio davanti a quello specchio, così che dovette fermarsi
e tornare indietro, per mettersi davanti allo specchio, immobile. E guardarsi.
...su per le labbra di Jun...
Era proprio di sera. Il sole, basso sulle colline,
coricava le ombre a dismisura. E si mise a piovere, così, d'improvviso. Magia.
Gli scese giù l'angoscia nell'anima come un sorso di
acquavite giù per la gola... impazzì tutto d'un fiato... non come quelli che lo
fanno un po' per volta...
Lascia che bruci, quella candela, non spegnerla, per
favore. Se mi vuoi bene non spegnerla.
Il signor Rail è partito. Il signor Rail tornerà.
Si ricordava tutto ma non il nome. Si ricordava anche
il profumo che aveva. Ma il nome no.
... che se a uno glielo chiedessero, di che colore è il
cristallo, questo vaso di cristallo ad esempio, di che colore è, e lui dovesse
proprio rispondere, rispondere con il nome di un colore...
Ma quella era l'ultima frase del libro.
Una lettera che uno aspetta da anni e poi un giorno
arriva.
E poi alla fine posare la testa sul cuscino per...
Corre, Pit, pieno di lacrime, corre a perdifiato, il
ragazzino, gridando “Il vecchio Andersson, il vecchio Andersson”, grida e
corre, pieno di lacrime.
Quando ti alzi e tutto il mondo è ghiacciato, e tutti gli alberi del mondo ghiacciati, e tutti i rami di tutti gli alberi del mondo ghiacciati.
Milioni di aghi di ghiaccio che filano la gelida
coperta sotto cui poi...
L’ho sentito benissimo. Era un grido, quello.
TRE – Cap.2
Il vecchio Anderson morì con il cuore spaccato, quella
notte stessa, mormorando una sola, esatta, parola: “Merda”.
con il cuore spaccato, quella notte
stessa, mormorando una sola, esatta, parola: “Merda”.
quella notte stessa, mormorando una sola,
esatta, parola: “Merda”.
mormorando
una sola, esatta, parola: “Merda”.
una sola, esatta, parola.
una sola.
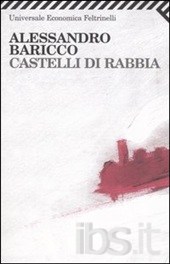
Nessun commento:
Posta un commento